Problema 518
Propuesto por Juan Bosci Romero Márquez, profesor colaborador de la Universidad de Valladolid
Sea ABC un triángulo con ángulo mayor en A, y lados a ³ b ³ c . Tracemos sobre el interior del lado mayor BC opuesto al ángulo A, los puntos P y Q tales que BP=a-b y QC=a-c.
Sean las alturas trazadas desde los vértices P y Q de los triángulos ABP y ACQ y sus pies P´y Q´sobre sus lados opuestos AB y AC respectivamente.
Probar que :
a) ![]()
![]()
b) ![]()
![]()
c) Son a) y b) dos caracterizaciones equivalentes de la clase de triángulos según los ángulos?
Romero, J.B. (2009): Comunicación personal
Solución de Gennaro Rispoli, docente di
matematica al Liceo Scientifico
Sperimentale annesso al Liceo Ginnasio "T.L. Caro", 84087 Sarno
(Salerno), Italia.
Considerazioni preliminari
Con BC = a, CA = b, AB = c, costruiamo la circonferenza di centro B e raggio c e quella di centro C e raggio b ottenendo i punti P e Q su BC. Così abbiamo BP = a-b e QC =a-c.
Abbiamo inoltre PQ =a-BP-QC=a-(a-b)-(a-c)=b-a+c.
Fig.518/1
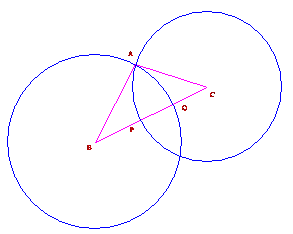
Situazione problematica posta al punto a)
Con PQ = b-a+c, BP = a-b e QC =a-c abbiamo intanto:
PQ2=b2+ a2+ c2-2ba+2bc-2ac e 2 BP QC= 2(a-b)( a-c)= 2( a2-ac-ba+bc)
Caso del triangolo rettangolo. ÐA= 90°.
Se ÐA= 90° abbiamo a2=b2+ c2 per mezzo del teorema di Pitagora.
Così abbiamo:
PQ2= b2+ a2+ c2- 2ba + 2bc -2ac = b2+ b2+ c2+ c2-2ba+2bc-2ac =2( b2+ c2-ba+bc-ac) e
2 BP QC= 2( a2-ac-ba+bc)=2(b2+ c2-ac-ba+bc).
Pertanto la differenza di tali espressioni è uguale a 0. PQ2-2 BP QC =0.
Se invece PQ2-2 BP QC =0, cioè b2+ a2+ c2- 2ba + 2bc -2ac -2( a2-ac-ba+bc) =0 abbiamo b2+ a2+ c2= 2 a2 cioè b2+ c2 = a2. Pertanto il triangolo è rettangolo. ÐA= 90°.
La situazione con Cabri è quella mostrata di seguito. Fig. 518/2.
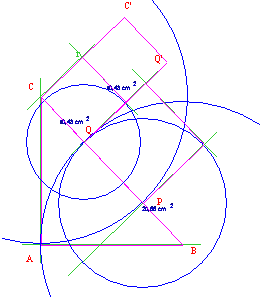
Caso del triangolo ottusangolo. ÐA > 90°.
Con le dovute semplificazioni l’espressione PQ2-2 BP QC diviene b2 + c2- a2. Dal teorema del coseno o teorema di Carnot (Lazare- Nicolas, 1753-1823) abbiamo a2= b2+ c2- 2bc cos( ÐA). Pertanto l’espressione b2 + c2- a2 diviene 2bc cos( ÐA).
Se ÐA >90° abbiamo cos( ÐA) <0 allora 2bc cos( ÐA)< 0. Se invece 2bc cos( ÐA) <0 abbiamo cos( ÐA) <0 ovvero ÐA >90°.
La situazione con Cabri è quella mostrata di seguito. Fig. 518/3.
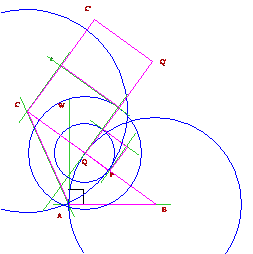
Caso del triangolo acutangolo. ÐA < 90°.
Valgono considerazioni analoghe a quelle appena trattate.
Situazioni problematiche poste ai punti b) e c)
Costruiamo in primis le altezze hP =PP’e hQ =QQ’dei triangoli indicati APB e ACQ, poi due circonferenze, una di centro P e raggio PP’ e l’altra di centro Q e raggio QQ’. Vediamo che la situazione proposta diviene un problema di posizioni reciproche di due circonferenze, che possono essere tangenti esternamente o secanti o esterne. La retta PQ diviene la retta dei centri di tali circonferenze, la retta tracciata per gli eventuali punti comuni è invece l’asse radicale delle stesse circonferenze.
Caso del triangolo rettangolo. ÐA= 90°.
Consideriamo la retta AA’ asse radicale delle circonferenze originarie che individuano i punti P e Q situati sul lato BC. Così AA’C e ABA’sono triangoli isosceli che condividono il lato AA’.
Sia H inoltre il punto di intersezione di AA’ con BC. Vediamo che le circonferenze aventi rispettivamente come centri P e Q e raggi hP =PP’e hQ =QQ’ sono tangenti esternamente. Pertanto la distanza tra i centri P e Q è uguale alla somma dei raggi hP =PP’e hQ =QQ’. Donde la tesi.
Fig.518/4
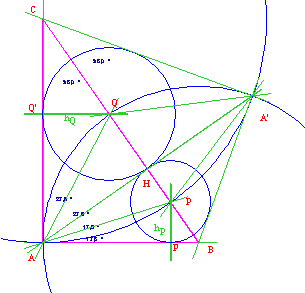
Caso del triangolo ottusangolo. ÐA > 90°.
Vediamo che le circonferenze aventi rispettivamente come centri P e Q e raggi hP =PP’e hQ =QQ’ sono secanti. Pertanto la distanza tra i centri P e Q è minore della somma dei raggi hP =PP’e hQ =QQ’. Donde la tesi.
Fig.518/5
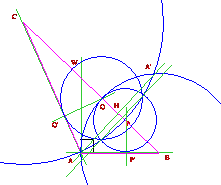
Caso del triangolo acutangolo. ÐA < 90°.
Vediamo che le circonferenze aventi rispettivamente come centri P e Q e raggi hP =PP’e hQ =QQ’ sono esterne. Pertanto la distanza tra i centri P e Q è maggiore della somma dei raggi hP =PP’e hQ =QQ’. Donde la tesi.
Fig. 518/6
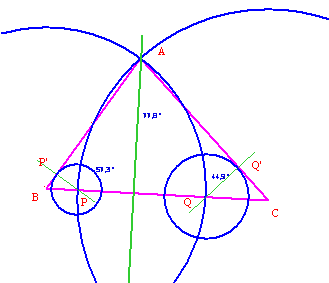
Le riflessioni esposte sopra risolvono anche la questione posta al punto c).